 Nefasti della memoria
Nefasti della memoriaI «fasti del quarantennale», cioè le celebrazioni in ricordo del sequestro di Aldo Moro nel 1978, hanno mostrato il carattere nefasto delle ricostruzioni memorialistiche, che, proprio poiché capaci di bypassare il tempo trascorso e le ricostruzioni storiche, anziché sollevare interrogativi provocano ed alimentano sentimenti.
Interamente nelle mani di politici e giornalisti, nell'assordante silenzio degli storici e nell'assenza integrale degli ex-brigatisti, il discorso pubblico, incentrato sulle vittime del terrorismo, ha raggiunto rapidamente toni da campagna d'odio. Giornalisti di fama si sono lasciati andare ad insulti, scrivendo di voler sputare addosso agli ex-brigatisti, e scatenando così i tanti giustizieri dell'internet, sdoganati nella rincorsa a chi propone le peggiori umiliazioni e punizioni. Perché sembra che quei fatti siano appena avvenuti, ieri o l'altroieri, e l'emergenza sia in corso.
Davanti ad immagini di cadaveri e di sangue, basta gridare quello è l'assassino e non importa più che in quattro decenni il paese sia cambiato, la storia abbia fatto il suo corso, e che gli autori condannati abbiano fatto in tempo a scontare le massime condanne nelle peggiori condizioni possibili.
Tra le rarissime voci critiche, spicca per importanza l'articolo di Ilenia Rossini, dedicato a 'L’indicibilità della critica della vittima': lo prendiamo come punto di partenza per quanto segue, un contributo al dibattito nato inizialmente come commento.
Quelle 'Note sulle polemiche del quarantennale' vanno dunque lette, così come il saggio a cui fanno riferimento, 'Critica della vittima' di Daniele Giglioli, (che chi vuole può leggere qui per decidersi a comprarlo).
Il paradigma vittimario in azione
L'articolo su Zapruder, che osa prendere di petto la censura andando al centro della questione tabuizzata della 'vittima', ricostruisce alcuni passaggi dell'affermarsi del paradigma vittimario. Qui si vorrebbe contribuire richiamando alcuni aspetti non menzionati, seguendo l'idea che il capire 'come funziona' possa aprire a una lettura più ampia.
L'esposizione al pubblico -attraverso un medium qualsiasi- di una vittima -una persona, un gruppo o una collettività che soffre per subire o aver subito una forza, sia essa naturale o umana, senza disporre di mezzi per controllarla o affrontarla- provoca principalmente emozione in chi la recepisce. Un pathos, una com-passione dell'essere umano verso suoi simili, le cui condizioni riconosce come drammatiche. Benché lo schema si applichi anche ad altro (si pensi ad esempio ad immagini di animali brutalizzati), fin qui siamo al senso comune (del sentire comune). Questo pathos condiviso è il primo passo verso la sedimentazione di un valore morale che motiva la messa in opera di ciò che Boltanski chiama 'programma d'azione'.
Il programma d'azione, spesso già insito nella forma di esposizione della vittima al pubblico, può orientarsi verso la carità o verso il suo opposto, la giustizia. Si vuole portare aiuto alle vittime, lenire il loro dolore, o prendersela con chi di quella sofferenza è responsabile. Qui siamo già nel politico, quindi questo è solo lo schema di partenza dell'elaborazione dei programmi d'azione, che si possono combinare e sviluppare, stante che gli orientamenti restano nella prospettiva del 'bene'.
Si vedano come esempio le guerre che già vent'anni fa venivano vendute come 'umanitarie', scatenate esplicitamente in nome delle vittime, ed il loro pendant, la mobilitazione del soccorso umanitario ai rifugiati, alle vittime del conflitto. La guerra umanitaria è portatrice di 'giustizia', poiché pretende fermare i carnefici, punirli, e ristabilire un ordine 'giusto', poco importa che i bombardamenti producano inevitabilmente altre vittime, saranno categorizzate come danni collaterali. Il programma d'azione orientato alla giustizia presuppone l'esistenza, la costituzione o l'adesione ad un collettivo dotato del potere simbolico di perseguire il colpevole delle disgrazie delle vittime.
È forse il più in auge, poiché come dispositivo si fonda su una struttura solida e vicina al senso comune. La sua base è la categorizzazione della coppia vittima-carnefice; inscindibile, poiché non c'è vittima senza un carnefice, e viceversa. La terza figura necessaria è quella del 'giudice', che si forma come autorità capace di fare giustizia, e quindi di punire il carnefice. Il modello si completa con la figura del denunciatore o accusatore, tradizionalmente ammantato di una certa neutralità in quanto 'testimone' od 'esperto'.
Applicato alla comunicazione pubblica, lo schema mostra tutta la sua efficacia: la narrazione dei media mostra le vittime ed indica il colpevole, il giornalista prende il ruolo dell'accusatore e attribuisce il ruolo di giudice agli spettatori. (Dai processi televisivi sappiamo poi che lo spettatore-giudice scruta le espressioni dell'accusato per trovar conferma alla colpa, ma restando in termini generali, il messaggio produce quel sentimento d'indignazione che può portare alla mobilitazione).
Questo dispositivo ha inoltre la qualità di potersi sviluppare, anche applicandosi 'contro sé stesso', senza modificarsi. È nel gioco dell'inversione di ruoli, che si sviluppa la forma 'affaire' (sempre Boltanski), il cui archetipo è l'affaire Dreyfuss. Con la pubblicazione del suo famoso «J'accuse!» (nel 1898) Emile Zola pone lo sfortunato Capitano, detenuto all'Isola del Diavolo, nel ruolo della vittima, perché innocente, denuncia nel ruolo di carnefice il sistema che l'ha condannato, e, rivolgendosi al pubblico, provoca la costituzione di un collettivo che si sente simbolicamente incaricato di (ri-)stabilire giustizia. Naturalmente la cosa non si ferma lì, la controversia cresce con contro-accuse (che attaccano per esempio il ruolo di denunciatore) e sviluppa scontri politici, ma alla base resta sempre determinante chi ricopre quale ruolo.
Il potere di mobilitazione del paradigma
L'esposizione pubblica di vittime e carnefici non genera solo 'propaganda politica' come nel caso delle guerre umanitaire di cui s'è detto, dove il dispositivo serve ad ottenere consenso per un programma d'azione -giustizia e aiuto- comunque condotto dall'autorità del governo o dello Stato.
Se il sentimento di vicinanza alle vittime è sviluppato fino all'identificazione con esse, fino al sentirsi potenziali vittime di una minaccia non scongiurata, e se l'indignazione può cristallizzarsi contro uno 'scandalo', si può assistere a straordinarie mobilitazioni di massa.
Nel 1996 in Belgio prese forma la «Marche blanche» attorno al caso Dutroux, autore di rapimenti, abusi e omicidi di bambini. Le dimensioni della manifestazione (tra i 300' e i 600'000 partecipanti secondo le stime) ed i suoi tratti (silenzio, colore bianco in segno di neutralità) la resero senz'altro un episodio unico, ciononostante significativo. La mobilitazione attorno alle famiglie colpite da crimini tanto odiosi traversò tutte le divisioni tradizionali del paese (operai e borghesi, walloni e flaminghi, credenti e liberi pensatori) e fu orientata contro il disfunzionamento degli apparati statali. L'omaggio alle povere vittime -questo l'intento dichiarato della manifestazione- mirava quindi ad estendere il ruolo del carnefice verso i suoi possibili complici. Sul bastardo assassino non c'era dubbio né questione possibile, ma chi aveva permesso che venisse scarcerato, chi direttamente o indirettamente l'aveva aiutato? Il sospetto -al di là della legittimità delle domande, facendo astrazione dal caso- di trovarsi di fronte ad una forma di intrigo o di complotto, all'esistenza segreta di altri attori ed interessi, forse tanto potenti da non poter essere rivelati, può aumentare la pietà per la vittima ed essere quindi fattore di mobilitazione, ma si risolve in genere in una maggiore stigmatizzazione del carnefice.
Quid: e i delitti senza vittima? Possono essere senz'altro vettori di mobilitazione di massa.
Qui ci troviamo nel simbolico -appunto non c'è una vittima in carne ed ossa- e quindi è una pacchia per la politica. L'esempio tipico è la corruzione, dove l'identificazione della vittima passa per un costrutto etico-giuridico (la 'teoria del terzo escluso', Meyer-Bisch, Borghi et al.) che lascia di fatto il ruolo senza un corpo. Niente di più facile nel discorso pubblico che il ruolo di vittima venga assunto dal 'popolo'. Basti ricordare lo slogan «Ladri! Ladri!» indirizzato a corrotti e corruttori: la vittima di un ladro è la persona derubata, e se chi mi governa e mi amministra ruba, la vittima sono io. In quanto tale sono parte di un collettivo che ha il potere simbolico di esprimersi pubblicamente -cosa che in quanto semplice cittadino non ho.
L'Italia ha conosciuto 'Mani Pulite', ma la storia internazionale è costellata da mobilitazioni contro la corruzione, tutte rese possibili da una strategia di occupazione del ruolo simbolico di vittima. Per ricordare come queste non conoscano frontiere culturali o ideologiche, valga menzionare che già 30 anni fa, le manifestazioni nella Repubblica Democratica Tedesca che portarono alla caduta del muro di Berlino come pure le famose giornate della Piazza Tiananmen a Pechino, furono mobilitazioni di massa proprio contro la corruzione.
E probabilmente proprio l'efficacia del semplice sistema d'identificazione simbolica nel ruolo (non occupato) di vittima, permette che dei programmi d'azione dai tratti assai radicali vengano messi in opera: tra il 1984 ed il 1997, non meno di 23 colpi di stato, ammutinamenti e 'putsch bianchi' sono stati tentati in altrettanti paesi, tutti in nome della lotta alla corruzione.
Politiche vittimarie
Nei paesi usciti da conflitti interni, a partire da quelli scoppiati nella seconda metà del secolo scorso, si sono sviluppate diverse forme di giustizia transizionale. Per fare i conti col passato, ogni paese s'è dotato di organismi e strumenti giuridici diversi, spesso facendo ricorso all'istituzione di Commissioni intitolate alla Verità, alla Giustizia, alla Riconciliazione e alla Riparazione.
Quattro valori che peraltro entrano in concorrenza, e danno luogo a diverse combinazioni (con per esempio comitati specifici orientati all'uno o all'altro valore), tutte incentrate sulla figura della vittima.
E c'è di che, se si pensa che in Argentina v'erano tra le 10'000 e le 30'000 persone scomparse. Con decine di migliaia di famiglie che non sapevano più nulla dei propri cari, la ricerca della verità riguardava le domande di base: dove sono, che fine hanno fatto?, come in un'inchiesta quando il reato è ancora in corso. Del resto proprio le madri e nonne dei desaparecidos, riunendosi silenziosamente di giovedì, con foulards bianchi, sulla Plaza de Mayo, avevano permesso al mondo di aprire gli occhi sulla drammaticità della repressione prodotta dalla crociata anticomunista. La prima Commissione, la CONADEP, si dedicò a quella ricerca, pubblicando i risultati nel famoso volume 'Nunca màs'.
In Sud Africa, la Commissione s'intitolò alla Verità e alla Riconciliazione, usando un sistema di amnistie individuali per favorire le confessioni pubbliche dei carnefici di fronte ai familiari delle vittime, che spesso non sapevano nulla di quanto fosse realmente accaduto. Tentò così di integrare dei procedimenti di giustizia riparativa, sollevando anche l'opposizione di alcune famigle di vittime, tra cui quella di Steve Biko, che però venne respinta perché l'orientamento principale della Commissione era di conoscere la verità dei fatti e poter fornire un quadro d'insieme. Le vittime, erano quelle di entrambe le parti, dei torturatori come dei terroristi.
Si può continuare, il Cile, il Brasile (dove non vi sono confessioni di torturatori), il Perù (dove la maggioranza delle vittime erano dovute a Sendero Luminoso), c'è un lungo elenco di paesi e situazioni (oltre 30), non facilmente comparabili e ancor meno riassumibili in poche parole, che hanno ricorso alla giustizia transizionale. In generale, si può dire che condividano la verità come orientamento primario, poiché questa è considerata come condizione necessaria sia per la giustizia che per la riconciliazione.
La giustizia di transizione è usata per legittimare il nuovo regime, permettendogli di alleggerirsi del fardello di sofferenze per la memoria del conflitto, facendo fronte ai conflitti di memorie e al potere conservato dai membri del regime precedente, producendo una memoria ed una politica memoriale. È perfettamente coerente ad una tale fase storica che si possa aspirare ad una riconciliazione, intesa come un processo tra due parti, già in conflitto, che tende a ristabilire dei vincoli pacifici e di rispetto reciproco tra i membri di una comunità nazionale divisa; un processo che abbia la forma dell'accordo diretto, e che permetta alle parti in causa di uscire dal ruolo, sia quello di aggressore, terrorista, torturatore, vittima o carnefice.
Per Amnesty International, in un suo manuale sul come si fa una Commissione, i valori sono solo tre: Verità, Giustizia e Riparazione, e, per quest'ultima, con slancio normativo, precisa le forme: la restituzione, l'indennizzazione, il riadattamento, la soddisfazione e la garanzia di non ripetizione. La riconciliazione no, poiché non può essere imposta da un autorità, quasi che la verità invece sì. Ne risulta una impostazione marcatamente vittimo-centrica.
Osserva Paul Gready che la giustizia transizionale è diventata un'industria -lo dice sia come complimento che come allarme- sicché un paese che esce da una crisi interna troverà sul mercato i prodotti necessari, guide (come quella di Amnesty), coaching, un settore di studi con tanto di rivista, strumenti e chiarimenti normativi.
D'altra parte, anche la vittimologia s'è sviluppata offrendo le categorizzazioni che distinguono le vittime dai sopravvissuti, e le vittime primarie da quelle secondarie e terziarie.
E il diritto umanitario internazionale delimita l'attribuzione dello status di vittima, e dei diritti che l'accompagnano, secondo i crimini subiti.
Non dappertutto s'è seguito questo genere di percorso. Nei paesi che sono emersi dilaniando la Repubblica Federale di Jugoslavia, la figura della vittima ha giocato un ruolo assai importante per la costruzione della Nazione, e non solo.
Nella sua tesi del 2001, Bruce Mac Donald spiega come le élites nazionaliste sia di Serbia che di Croazia abbiano dapprima usato la paura di essere vittime di un genocidio per spingere i loro popoli ad una guerra di 'autodifesa': Slobodan Milosevic inventando una 'Serbofobia' alla luce della quale rileggere la storia dei Serbi come la tragedia di un susseguirsi di episodi di persecuzione e vittimizzazione ad opera di forze negative esterne; quasi simmetricamente, Franjo Tudjman agitava lo spettro della 'Grande Serbia' fino a farlo divenire una sorta di anti-semitismo contro i Croati. Fu così che le vittime immaginarie si dedicarono a campi di concentramento, pulizie etniche e barbarità varie che produssero vittime vere.
La costruzione della mitologia nazionale rilesse gli episodi della seconda guerra mondiale e poi il conflitto appena vissuto in termini di genocidio, sia Serbi che Croati modificando le quantificazioni delle vittime 'a proprio favore'. La propaganda vittimo-centrica come motore della nation-building, calcata sul modello di Israele con la Shoah, è risultata produttiva.
Essere visti come vittima
Quid: e nei paesi dove non ci sono guerre civili, terrorismo, stragi, conflitti e nemmeno catastrofi? Basti un esempio dall'attualità. Erano chiamati Verdingkinder i bambini che in Svizzera venivano 'dati in affidamento', spesso ad agricoltori -si parla di un secolo, fino agli anni 1960-, o internati in manicomi e carceri, e molto spesso in condizioni orribili, di abuso, anche sessuale, maltrattamenti, fame, freddo, sfruttamento, depredamento, violenza, senz'ombra di affetto o calore umano. Riuscire a raggiungere la maggior età e 'liberarsi' da quella vera e propria forma di schiavitù -molti si suicidavano- significava poi tacere a vita perché non erano creduti. Per ripulire la brutta macchia sull'immagine di un pase sempre politically-correct, il governo decise di offrire a quelle vittime una riparazione, in denaro s'intende.
 Con decine di migliaia di casi, gli esperti si attendevano 20'000 richieste, ne sono arrivate appena 4'400. Il perché, è ben riassunto nel titolo di un quotidiano: 'Vittima una seconda volta? No grazie!' Ritornare in quel ruolo, non è solo riaprire vecchie ferite, è soprattutto essere ridotti a vittime, perché considerati e narrati solo come tali, e non come persone che hanno una vita in cui è successo anche quello. Cittadini, lo sono solo perché lo Stato vuole che riempiano un formulario, che al punto B3 dice: «Descriva brevemente perché si considera una vittima ai sensi della legge», e a quello successivo chiede l'elenco delle prove. A gente che già davanti ai ricercatori, che chiedevano di validare le carte di legge (tipo protezione dei dati), aveva rivissuto la condizione traumatica di non essere creduta: ma le mie parole non valgono nulla, devo firmare?
Con decine di migliaia di casi, gli esperti si attendevano 20'000 richieste, ne sono arrivate appena 4'400. Il perché, è ben riassunto nel titolo di un quotidiano: 'Vittima una seconda volta? No grazie!' Ritornare in quel ruolo, non è solo riaprire vecchie ferite, è soprattutto essere ridotti a vittime, perché considerati e narrati solo come tali, e non come persone che hanno una vita in cui è successo anche quello. Cittadini, lo sono solo perché lo Stato vuole che riempiano un formulario, che al punto B3 dice: «Descriva brevemente perché si considera una vittima ai sensi della legge», e a quello successivo chiede l'elenco delle prove. A gente che già davanti ai ricercatori, che chiedevano di validare le carte di legge (tipo protezione dei dati), aveva rivissuto la condizione traumatica di non essere creduta: ma le mie parole non valgono nulla, devo firmare?Qualche anno fa una rivista tedesca intervistò una vittima famosa che negli anni '70 era stata sequestrata e poi rilasciata in cambio di un riscatto, ed in seguito s'era tenuta in disparte. Il signor Oetker, figlio di ricchi industriali, era stato trattato brutalmente, chiuso in una cassa e sottoposto a scariche elettriche, e ne uscì con menomazioni a vita. Diceva: ciò che mi fa più male non sono i danni fisici che ho ricevuto, è lo sguardo degli altri.
La riduzione a vittima, è la raffigurazione di un essere sofferente, indifeso, innocente, passivo, perdente, impotente, incapace di prendere in mano il proprio destino.
Così vediamo -così si sente vista- una persona quando la categorizziamo secondo quel ruolo, il nostro sguardo stigmatizza la vittima con la stessa facilità con cui lo fa per il suo carnefice, i cui attributi sono ovviamente altri (colpevolezza, cattiveria, potere, arroganza, disumanità...).
C'è da chiedersi se il nostro sguardo sulla vittima, che ne riafferma la condizione, riattivandola e prolungandola nel tempo, non sia il prolungamento dell'opera del carnefice, che quella condizione ha iniziato.
Il fatto è che la inchiodiamo lì, in quel ruolo, a quella sofferenza originaria.
In Italia, alcuni familiari di vittime ripetono: Si può essere ex-brigatisti, ma non si può essere ex-assassini. Una frase ad effetto, letteralmente lapidaria, lanciata come uno slogan incontrovertibile (e nessuno replica, neppure con una parabola di un testo sacro). Anche da morto, l'assassino resterà tale, e qualche giornalista dirà di voler sputare sulla sua tomba.
Ma dicendo che un assassino non può mai essere ex-assassino, non si dice anche che la sua vittima non potrà mai essere ex-vittima?
Carnefice in eterno, vittima in eterno.
[Per garantire il 'mai', i figli delle vittime dovranno prendersela con i figli dei carnefici: lo slogan è quello della faida, propone l'odio come eredità. Se il desiderio di vendetta è un sentimento umano, e si riconosce come naturale che la vittima lo viva, è altrettanto umano e di buon senso che si plachi prima che produca una nuova vittima. La faida non ha questo buon senso, e consiste nello scambio, ripetuto in eterno, dei ruoli di vittima e carnefice tra due collettivi, che siano due gruppi famigliari o altro.]
Come ogni singola vittima gestisca la sua sofferenza o il rapporto col carnefice non è in discussione. Probabilmente non è neppure discutibile, si tratta della sfera intima dei sentimenti. Non accetto che il mio torturatore venga umanizzato da quel film, diceva una militante della lotta armata il cui corpo era stato straziato riducendola ad un oggetto; si riprese fisicamente, in libertà, ma mai psichicamente, la violenza le aveva devastato anche quella sfera intima, che permette di vivere.
Quando si parla del paradigma vittimario, di quel prototipo di rapporti simbolici che tanto piede ha preso negli ultimi anni, non si tratta dei singoli individui, ma dei collettivi e delle relazioni sociali che esso produce.
Organizzazione e memoria
I due esempi fatti prima, a proposito del potere di mobilitazione delle vittime, lo sono anche per la loro capacità di creare un'organizzazione. Il movimento della 'Marcia bianca' si sviluppò vertiginosamente nel giro di poche settimane, e creò centinaia di sedi locali in tutto il Belgio. Al suo apice, avrebbe potuto provocare una gravissima crisi interna, e l'aveva raggiunto, ottenendo l'attenzione costante dei media e configurando un problema sociale di primo rango (il sogno di tutti i populisti). È vero che le sedi locali scomparvero nei due anni successivi, ma fece scuola, si diffuse in altri paesi, ed è ancora un label che permette iniziative politiche e di lobbying nel campo della violenza sui minori, a cominciare dall'esecuzione pena dei pedofili.
Le 'Madres de la Plaza de Mayo' sono probabilmente anche le madri delle associazioni di vittime, se non altro simbolicamente, per notorietà e per coraggio. Furono infiltrate, sequestrate, torturate ed uccise, nella logica del 'togliere l'acqua in cui nuota il terrorista'. Una logica di sterminio, giustificata come parte di una crociata anticomunista mondiale ed applicazione di una dottrina di counter-insurgency.
Le Madri argentine sono ancora attive, ma anche frazionate. Un tema che le divide è la memoria: alcune vogliono che i figli siano ricordati per quello che erano, dei militanti. Persone coscienti, impegnate, che avevano scelto di lottare e di prendere le armi, legando il proprio destino a quello dei loro compagni. Non degli sfortunati che avevano subito impotenti un tragico fato. Non innocenti, ma neppure martiri o eroi, l'altro estremo che si può raggiungere via la narrazione di un comportamento esemplare, fino al sacrificio per la causa.

Una memoria focalizzata sul momento della tragedia finale, corrisponde ad una narrazione di sentimenti ancorata alla morte, alle sofferenze e al rifiuto della violenza, e produce una verità di tipo morale; dice questa è la vittima -l'essere umano attinto nei suoi diritti umani- e ciò è quanto le è accaduto -per colpa del carnefice, se c'è-, per gridare 'mai più!'.
Una memoria focalizzata sulle persone, corrisponde ad una narrazione di ricordi, orientati alla vita passata, fatta di relazioni e di idee, di passioni e di ragioni, di conflitti e di condivisioni, e produce una verità di tipo storico o testimoniale; dice questa è la persona, con ciò che ha fatto e in cui ha creduto -in relazione ai suoi simili- fino a che è scomparsa, e questi i fatti -le loro dinamiche- che hanno portato al tragico evento. Fornisce gli strumenti di conoscenza perché 'mai più' si ripetano le condizioni che hanno determinato il dramma.
Il legame organizzativo, l'associarsi, rende il gruppo un attore sociale che ha diritto di parola nello spazio pubblico (cosa che il semplice cittadino non ha) e che produce una memoria collettiva.
Molto più che la memoria individuale, che pure sceglie cosa dimenticare, quella collettiva stipula ciò che va ricordato e come va ricordato, la narrazione che ne va fatta, sapendo che si confronterà con altre narrazioni alla ricerca di un consenso pubblico più vasto.
Vittimizzatori
Non c'è solo questo movimento 'dal basso', spontaneo, che crea un collettivo, le persone colpite dalla stessa atroce catastrofe che si ritrovano per affrontare il male comune e ottenere ascolto.
La vittimizzazione 'dall'alto' consiste di strategie di reclutamento indirizzate a gente cui viene offerto il ruolo simbolico di vittima: si propone loro un'identità generatrice di diritti.
La chiave di queste strategie risiede sempre nella categorizzazione del 'carnefice', e più precisamente nella definizione di vittima 'di cosa' o 'di chi', spesso poi seguite, soprattutto nelle definizioni di legge che ne statuiscono i diritti, dalle qualificazioni soggettive delle vittime, per esempio se si tratti di 'cittadini incolpevoli' o no.
Lo si può notare già nell'associazionismo, le definizioni subiscono un processo di semplificazione, di sfumatura, di estensione o di 'bridging', ciò che consente alla categoria di includere un numero maggiore di coinvolti.
A titolo d'esempio, l'Associazione internazionale delle vittime del terrorismo comprende anche le vittime 'di odio religioso, razziale e di atti di sangue nel mondo, generati da un gesto di intolleranza a causa delle differenti ideologie politiche'.
L'appiattimento allo status di vittima produce un calderone di cuori neri e cuori rossi -ma senz'altro anche verdi e d'altri colori- tutti uniti nel sangue e nella sofferenza e sordi alle differenze. Oblio sulle storie politiche che le hanno generate, quelle 'vittime'. Damnatio memoriae sui caduti non classificabili come vittime, finché un collettivo non li includerà nella sua memoria, magari come eroi.
C'è una critica di destra alla vittimizzazione.
Lo statunitense Bruce Bawer, col suo pamphlet del 2012, mette all'indice lo sviluppo, nel mondo accademico, degli 'identity studies'. Causa del vittimismo imperante sarebbe la visione 'marxista' che fonda Women's, Black, Queer, e Chicano Studies, tanto per cominciare.
Sul banco degli accusati troviamo il Fanon dei Dannati della terra, il Freire della Pedagogia degli oppressi, il Gramsci dei Quaderni dal carcere per il concetto di egemonia e quello di subalternità ripreso da Spivak, fino al Said di Orientalismo, tutti uniti nell'imporre una visione politica del mondo incentrata sulla contrapposizione tra vittime e carnefici. Il tutto a detrimento della 'nazione più libera e più prospera della storia dell'umanità, l'America' (gli Stati Uniti).
Il britannico David G. Green (2006) ritiene che il diffondersi del vittimismo sia incompatibile con il liberalismo, ed esamina l'affermarsi, grazie alla vittimizzazione come strategia di acquisizione di potere politico, dei gruppi sociali protetti. Contando i membri delle categorie -donne, gay, disabili, minoranze etniche- cui è attribuito lo statuto di vittima, calcola che in Gran Bretagna coprano tra il 73% ed il 106% della popolazione. È il 'collettivismo settario', che va oltre l'associazionismo -che punta ad ottenere riparazioni- per chiedere il riconoscimento politico di uno stato permanente di vittima capace di attribuire ai gruppi una protezione speciale ed un trattamento preferenziale usando i mezzi coercitivi dello Stato, a mettersi in contrasto con il liberalismo. Nato con i movimenti per i diritti civili degli anni '60, e dotato di varianti tra le quali l'odierno multiculturalismo è la più dannosa, il collettivismo settario rappresenta una pericolo per la democrazia, ché ne mina valori quali l'uguaglianza morale.
In realtà non è difficile vedere come la destra usi con nonchalance la propaganda vittimaria, si pensi alle 'vittime del comunismo' che fu tema portante nella Guerrra fredda e che continua ancora oggi.
 Oltre ai diversi memoriali costruiti negli ultimi anni (a Washington, Ottawa, Mosca, Praga, Bucarest...), nel novembre 2017, in occasione del centenario della Rivoluzione russa, Donald Trump ha istituito la giornata nazionale per le Vittime del Comunismo.
Oltre ai diversi memoriali costruiti negli ultimi anni (a Washington, Ottawa, Mosca, Praga, Bucarest...), nel novembre 2017, in occasione del centenario della Rivoluzione russa, Donald Trump ha istituito la giornata nazionale per le Vittime del Comunismo.Eppure la critica di destra è una riprova di quanto il problema sia esteso ed aperto, vede la dimensione politica del paradigma vittimario (status di vittima come produttore di diritti speciali permanenti) e mette il dito su piaghe effettive (eccessi della vittimizzazione dall'alto e derive discorsive nei gruppi 'vittimizzati').
Tanto che vien da chiedersi, sarà che tocca rivedere i fondamentali? Che magari Marx ed Engels abbiano aperto Il manifesto dei comunisti con una sfilata di vittime?
No, non è così, neppure nelle espressioni di disprezzo verso il sottoproletariato si tratta di 'vittime dell'oppressione', al contrario le categorie di oppressori ed oppressi descrivono le classi sociali in lotta, viste come motore dello sviluppo storico. E dovrebbe essere superfluo ricordare la differenza tra una classe 'in sé' -la sua mera descrizione socioeconomica- e una classe 'per sé', cosciente di esserlo e del proprio ruolo storico.
L'idea di autodeterminazione di oppone alla posizione di vittima. Così Lenin: Uno schiavo che non ha coscienza di essere schiavo e che non fa nulla per liberarsi, è veramente uno schiavo. Ma uno schiavo che ha coscienza di essere schiavo e che lotta per liberarsi già non è più schiavo, ma uomo libero. Neppure il principio di solidarietà si declinava, nella tradizione comunista e rivoluzionaria, in termini vittimari: Creare due, tre, molti Vietnam, slogan e dottrina del Che Guevara, significava l'esatto contrario contrario di correre con azioni cavalleresche a sostegno delle vittime dell'imperialismo.
Vittima 2.0 e post-vittimismo
Oggi si tematizzano le vittime dello schiavismo, del colonialismo, del neo- e post-colonialismo, e così via, coprendo di nebbia la storia, e anche i movimenti legati al principio di autodeterminazione sembrano essere sempre più attinti dalle politiche fondate sul paradigma vittimario.
Il movimento femminista ci porta un esempio d'attualità con la campagna #MeToo contro molestie e violenze sessuali subite dalle donne. Con quell'hashtag quale ognuna può dire 'io sono la vittima e questo è il mio predatore' rendendo immediatamente pubblica la sua denuncia. In quanto forma di discorso pubblico, il suo precedente più noto è 'Je-Suis-Charlie', slogan di identificazione con le vittime del terrorismo di Charlie Hebdo (2015), poi declinata in 'Je-Suis-Paris' e decine di altre
 varianti per altrettanti successivi attentati con vittime, tanto da determinare una macabra concorrenza e comunque una saturazione. Prima, in reazione agli attentati dell'11 settembre 2001, c'era stato il 'Nous sommes tous Américains', dal titolo dell'editoriale, firmato dal direttore di Le Monde, Colombani, che probabilmente nessuno ha davvero letto o ricorda: la sua interpretazione come 'siamo tutti vittime' bastò a farne uno slogan politico importante.
varianti per altrettanti successivi attentati con vittime, tanto da determinare una macabra concorrenza e comunque una saturazione. Prima, in reazione agli attentati dell'11 settembre 2001, c'era stato il 'Nous sommes tous Américains', dal titolo dell'editoriale, firmato dal direttore di Le Monde, Colombani, che probabilmente nessuno ha davvero letto o ricorda: la sua interpretazione come 'siamo tutti vittime' bastò a farne uno slogan politico importante.Più indietro nell'albero genealogico, ancora due espressioni famose, prive però della prosepttiva vittimaria: il 'nous sommes tous des juifs allemands' del maggio 1968, risposta beffarda ai commenti del segretario del PCF Marchais sul movimento; e il 'Ich bin ein Berliner' pronunciato da John Fitzgerald Kennedy nel 1963 davanti al muro a Berlino Ovest, discorso anticomunista privo di retorica vittimistica.
#MeToo rappresenta la maggiore evoluzione del paradigma vittimario nel discorso pubblico: la persona assume il ruolo di vittima in modo diretto e immediato, assieme a quello del denunciatore, designa chi è nel ruolo del carnefice, condivide col pubblico il ruolo di giudice e quello di esecutore della pena -nella misura in cui si consideri pena la gogna pubblica cui è esposto il carnefice via l'internet- e lo fa come parte di un gruppo sociale. Un carico di potere simbolico davvero notevole, reso probabilmente possibile dall'uso di un social media qual'è Twitter. La campagna ha avuto il successo di 'evento virale dell'anno', contando milioni di tweets, estendendosi e replicandosi in un centinaio di paesi, (#moiAussi in Canda, #YoTambién in Spagna, #QuellaVoltaChe in Italia e il più esplicito #BalanceTonPorc in Francia), riuscendo ad imporre il tema all'agenda mediatica ed a affermarlo, in misura diversa secondo i paesi, come un problema sociale attuale, che quindi provoca la reazione delle istanze politiche.

Quella di Donald Trump, via Twitter, è focalizzata sulle vittime DI #MeToo -cioè sui predatori denunciati le cui vite sono sconvolte e distrutte da semplici accuse-, secondo lo schema Dreyfuss, e rifonda il quadro attribuendo il ruolo di vittima all'accusato. Ma è ovvio che critiche e reazioni sono andate ben oltre il richiamo dei principi di presunzione d'innocenza e di equo processo. Per esempio seguendo un altro grande schema classico (Blaming the victim, di W. Ryan, è del 1970), quello che questiona l'innocenza della vittima. Una vittima non-innocente può essere stata concausa del proprio male, non è credibile, e il suo stesso ruolo di vittima è dubbio. O ancora questionando il metodo, che appare come un 'disumanizzare il disumanizzatore', cioè di fare al carnefice qualcosa di analogo a ciò che egli ha fatto.
Il punto però è che #MeToo nasce nell'ambito del movimento femminista, che si è sviluppato sui principi dell'autocoscienza e dell'autodeterminazione delle donne, che vanno nel senso opposto alla vittimizzazione. Se v'è chi lo legge come una tecnica di autodifesa femminista, la contraddizione è però apparsa più evidente e sentita: 'Com'è difficile sottrarsi all'industria delle vittime', scrive in proposito Guia Soncini.
Che la contraddizione non fosse nuova era già evidente a molte altre, tra le quali spicca Nicoletta Poidimani, per il lavoro iniziato da qualche anno attorno all'idea di un approccio 'post-vittimistico'.
C'è da augurarsi che quella ricerca continui e si trasmetta ad altri movimenti, nessuno essendo immune al paradigma vittimario e al suo portato di innovazione sociale che ha i tratti, per usare l'espressione di Fassin e Rechtmann, di una 'riconfigurazione dell'economia morale contemporanea'.
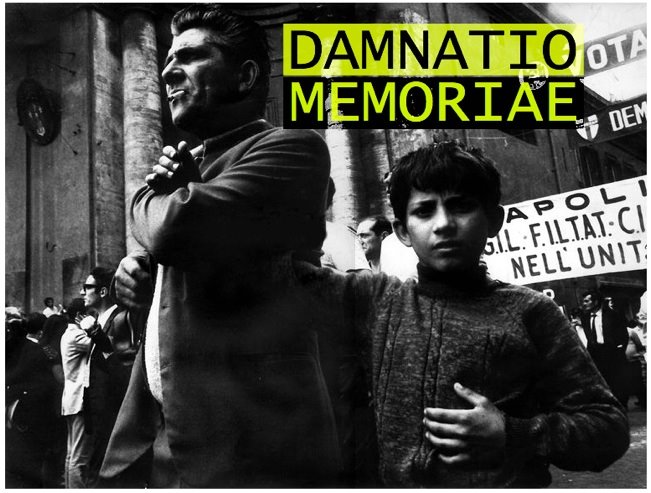


Articolo interessantissimo, ma che non coglie che il fenomeno e non la vera origine della "vittima eterna" come metodo per silenziare ogni oppositore. La cosa è partita dalla Shoah e è stata usata come mezzo ben al di là della sua funzione storica e legittima, ma come strumento per creare una èlite che non può e non deve essere messa in discussione. Sembrava l'arma perfetta contro ogni critica, ma il golem - non a caso tutto torna - si è rivoltato e ha iniziato a essere usato da chiunque volesse crearsi una corazza di insindacabilità: musulmani, popolo LGBT, minoranze varie, partiti e movimenti. Ora viviamo in un universo di vittime rancorose e idrofobe, ognuna convinta di possedere il titolo di insindacabile/inattaccabile/inquestionabile pena raffigurare l'altro come il nazista-aguzzino del momento. Io ho solo gusto che tutto ciò sia diventato un virus, una tabe, una lebbra, una disonestà profondamente truffaldina e vile. Il golem è fuori controllo. Godetevelo. Fino al punto in cui ogni senso di giustizia e ogni capacità vera di riconoscere una vera vittima non sarà andato in malora per abuso e overdose del farmaco! Allora sarà un'alba nuova e terribile.
RispondiElimina