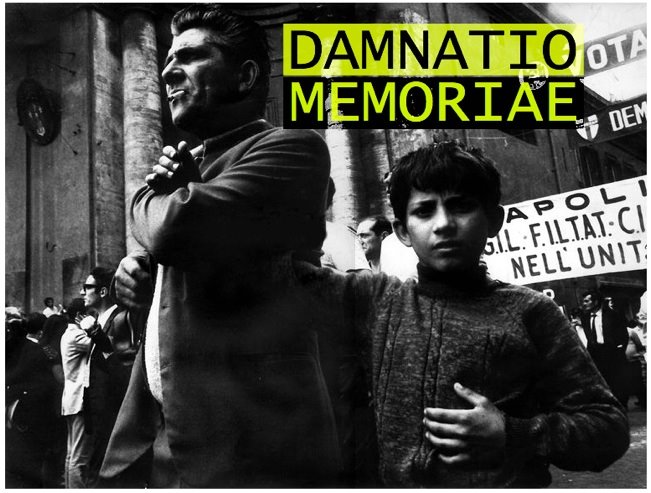È un testo quasi privato, quello che segue. Non era destinato al colto pubblico, ma alla sola inclita guarnigione, che ne aveva fatto gentile richiesta.
"Davvero torni a casa? Me lo devi raccontare perbene"
"Farò un diarietto. Promesso."
Era il 2010, e dopo 30 anni di esilio Paola De Luca poteva 'rientrare' in Italia. Tornare a casa, rientrare nel paese, sono modi di dire, immaginarî, supposizioni, da trent'anni la casa è altrove, non è un ritorno, non si ricomincia da 'dove eravamo rimasti?'.
Il rito di passaggio dell'uscita dal carcere è conosciuto, e si può capire che molti possa significare tirar giù la saracinesca sulla galera che ci si lascia alle spalle.
Ma quello dall'esilio? L'esilio non esiste, nessuno lo decreta, perché è una pena equiparata alla pena di morte. E l'esilio da un regime democratico, esiste ancora meno, perché è innominabile. I fuggitivi sono criminali comuni, delinquenti ricercati, dicono: anche se la stessa identica cosa la proclamano i regimi autoritari, teocratici, tirannici o dittatoriali.