Ma è mellio in francios.
Vabbé te la mand.
Baciott,
zia"
E questo è il testo:
SOTTO FALSO NOME
Mi ascolti.
Quel nome l’ho portato per vent’anni. All’inizio, in Africa, mi venivano i brividi ogni volta che qualcuno mi chiamava.
“Marcella!” Non sopportavo il suono di quel nome.
Giulio mi aveva domandato se avrei potuto accettarne un altro.
Mi ricordo, stavamo a colazione, pessimo caffè nelle tazze e sole già opprimente, l’albero delle papaye di fronte a casa esibiva le mammelle verdi e oscene e ogni cosa mi sembrava ostile, non un rumore o un odore m’erano familiari. Ero in sovrimpressione sul paesaggio.
Un altro nome?
Ci ho pensato per un po’ e non ho mai trovato una risposta.
Il fatto è che non avevo scelta.
Quando decisi di scappare, un compagno m’aveva scovato il passaporto “è une simpatizzante del movimento, è d’accordo, la dichiarazione di furto la farà tra sei mesi, così starai tranquilla alle frontiere”
Figurarsi. Un doganiere in Niger aveva studiato a lungo la foto, incollata di fresco, con un timbro fatto a casa che bisognava scaldarlo per dargli un po’ di rilievo, me lo piazzavo sotto il culo durante le traversate dei paesi, mi ricordo ancora del contatto, non era sgradevole.
“Lei ha ventidue anni?” M’aveva chiesto, il doganiere, scrutandomi attentamente. Ne avevo dieci di più, invece, con qualche capello bianco già apparso sulle tempie. Ma bisognava recitare la parte e io la recitai, mostrai un po’ il seno, mi sentii miserabile.
“Sembra più vecchia”, mi mollò quello, sereno, e mi lasciò passare.
Marcella. Ma come ci si può chiamare così?
Giulio mi prendeva in giro, certo, con tutti i problemi che dovevamo risolvere quotidianamente – roba come sopravvivere, trovare da mangiare e da bere, un luogo per dormire, la ragione della presenza laggiù, che toccava poi fornire agli altri, sempre curiosi e indiscreti, con tutto ciò - dico - io facevo una fissazione su un nome che mi pareva sgraziato.
Finii per riderne con lui, ma nel profondo covavo una rivolta sorda.
Vent’anni di rivolta contro un nome. Mentre la rivolta che mi aveva portato in quei posti mi si dissolveva dentro come neve al sole, non ci potevo fare niente, la distanza non era più solo geografica, mi staccavo inesorabilmente dal mio passato combattente, ne vedevo oramai le faglie e le derive...
Occorreva portare tutto questo dolore complicato. E portarlo con questa identità aliena.
“Come si chiama la tua mamma?” domandò una bimbetta a mia figlia, stavamo nei giardinetti davanti alla cattedrale, due lebbrosi senza naso e senza dita affittavano bici, i ragazzini di strada non osavano neanche passare il cancello, stavano appiccicati alle sbarre di ferro nero e guardavano i bianchi divertirsi.
“Si chiama Marcella, ma non le piace”
“Dài, andiamo ora” dicevo io, lanciando monetine ai lebbrosi, che le afferravano coi polsi.
“Ma è vero che non ti piace, no?”
“Sì, è vero. E tu che ne dici, ti piace il tuo nome?”
“Oh sì! Ma posso cambiarlo se ne trovo uno migliore?”
“Dài, andiamo, ora”
Mia figlia crebbe, l’Africa mi aprì una porticina misericordiosa ove trovai un rifugio, un lavoro, un tempo per sopravvivere. La gente, in fondo, non era poi così curiosa. O forse ero io che non interessavo poi tanto.
Marcella si fuse nella scenografia sontuosa, l’albero della papaya continuò a mostrare i suoi seni pesanti, il basilico spuntava in una notte e era divorato dalle formiche il giorno dopo, io insegnavo la mia lingua a giovani universitari entusiasti e lavavo i panni alla fontana, con le altre donne che mi sfottevano – non ero brava come loro – ma senza cattiveria, ridevamo insieme.
Pensavo spesso alla vera Marcella, rivedevo la sua faccia da ragazzina sulla foto strappata, cercavo di immaginare quel che il tempo aveva fatto del suo sorriso, mi domandavo com’era la sua vita. Avevo deciso che era diventata medico, che si era sposata tardi e non aveva figli. La vedevo allegra, coraggiosa, estroversa.
A volte le scrivevo delle lunghe lettere, raccontandole della vita mia, col nome suo. Una volta volli ringraziarla per il rischio che aveva preso, ma non trovai le parole per dirlo. Mi venivano fuori robe grandiloquenti, o piatte. Comunque, strappavo tutte le lettere e andavo a gettare i pezzetti di carta al mare. Mi ricordo d’infinite cerimonie di questo genere.
Ero solo una vecchia prof eccentrica, in mezzo agli altri eccentrici che vivevano su questa terra tollerante e indifferente.
Alla fine mi sentii veramente a casa. Giulio lavorava come elettricista per i grandi hôtel dei bianchi e la Marcella che ero non s’innervosiva più per il ritmo pigro dei giorni o per la mancanza delle stagioni, aveva imparato a ciondolare sotto le acacie e pure, ogni tanto, a scrollarsi di dosso la responsabilità del mondo e dell’universo.
Fu proprio a quel punto che ci beccammo un’amnistia. Potevamo rientrare nel nostro paese senza andare in galera.
Ce lo ripetevamo, Giulio ed io, sorridendo beatamente, pur sapendo che il paese in questione non era più il nostro, vent’anni erano passati sul corpo e sull’anima, lontani da un territorio che era diventato esotico per noi.
Nostra figlia, che ci aveva passato tutte le vacanze scolastiche, ce ne riportava visioni che ci avrebbero impauriti, senza l’alta diga eretta dalla nostra memoria. Insomma, tornavamo a casa come tutti i migranti, plasmati ormai d’estraneità e di fantasmagoria del passato.
Il trentesimo giorno dopo il ritorno, ero perduta nella città, nel quartiere dove ero nata, stordita dai suoni nuovi e con tutti i ricordi a mezz’asta, e mi misi in testa di cercare Marcella.
Non la trovai nell’elenco, col nome suo, almeno. Normale, pensai, deve aver preso il nome del marito.
Mi piazzai tranquillamente davanti al telefono, decisa a chiamare tutti gli omonimi, fino a trovare un parente in grado di informarmi. Accesi una sigaretta e composi quattro numeri prima di cadere su un silenzio.
“Chi parla?” domandò infine una voce d’uomo.
“L’ho conosciuta quando eravamo ragazze, volevo avere sue notizie...”
Altro silenzio, poi l’uomo mi invitò a passare da lui “anche stasera, se vuole”.
Indirizzo, istruzioni per arrivarci, la voce era roca, quasi afona.
Durante il tragitto mi resi conto di com’era austera, anche, quella voce.
Mentre io avevo continuato imperterrita a portare a spasso la mia eccentricità africana in questa città ormai sconosciuta, e stavo per impormi a gente che non avevo mai visto, e il disagio ci avrebbe preso tutti alla gola, io e le mie divagazioni, loro e la loro realtà straniera.
Mi figurai delle persone intorno a una tavola, sentii distintamente il rumore assordante che possono fare tazze e piattini in mezzo a gente che non ha niente da dirsi, ero pronta a fare dietrofront, esitai, ma alla fine suonai alla porta indicata.
L’uomo che mi aprì era vecchio e calvo.
“Lei è...?”
Prima di riuscire a trattenermi, risposi “Marcella” Poi aggiunsi balbettando “cioè, volevo vedere Marcella...” e compitai il mio nome vero, che mi sembrò falso.
Tutto si rivelava diverso da come l’avevo immaginato.
Mi fece entrare in un appartamento pulito e triste, mi indicò una poltrona e si sedette davanti a me.
“Marcella è morta vent’anni fa”.
Tra di noi s’alzò il silenzio. Non sentivo più battere il cuore, restai come sospesa, fissando la pelle grigia del vecchio davanti a me, aveva pronunciato parole che mi scivolavano addosso senza trovare l’accesso alla mente, come, scusi? Morta? Marcella?
L’uomo carezzava il bracciolo del sedile con lo sguardo fisso a terra. Mani di operaio, con le unghie deformate.
“Non lo sapeva” disse calmo.
“No. E’ impossibile”
“E’ quello che mi ripetevo a quel tempo. E’ impossibile. Ventidue anni, ma si rende conto?”
“Non si muore a venti due anni” dissi io, con tutta la stupidità di cui sono capace.
“Invece succede... è successo. A mia figlia”
Un vecchio singhiozzo rintoccò fra di noi.
Quando ero scappata, si moriva facile, nella mia patria, si moriva giovani e si ammazzava parecchio.
“Una simpatizzante del movimento”, l’aveva definita il nostro compagno. Una manifestazione finita male? Un blocco stradale? I poliziotti ne abbattevano a decine, colpevoli e innocenti, avevano sparato su Marcella? Su questa ragazza generosa che mi aveva ceduto il passaporto? No, non potevo crederci.
“Ma come è...?” Impossibile dire la parola. Un singhiozzo giovane s’intrecciò all’antico.
“Nessuno ha saputo dirlo”
Si alzò, andò a cercare una caraffa d’acqua, riempì due bicchieri, si rimise seduto e mi guardò negli occhi. Piangevo.
“Andava tutto bene, studiava diritto, era così solida, sicura di sé, voleva dedicarsi alla politica...”
Alzai la testa. “La politica?”
“Voleva cambiare il mondo. A quei tempi tutti i giovani volevano cambiare il mondo.”
Non c’era giudizio, né critica, a alterare il tono sobrio.
“Parlava della condizione operaia, della mia... voleva fare del bene a tutti”
Gli vidi un sorriso che mi fece più male del sighiozzo.
“E che è successo?”
“Ha cominciato a deperire... Posso dirle esattamente quando ha cominciato”
Lo sapevo. Non volevo saperlo. Lo disse.
Avevano chiamato tutti i dottori possibili. Anche uno specialista che era venuto apposta dall’Ungheria per visitarla. Marcella non aveva nessuna malattia conosciuta, le avevano fatto tutte le analisi, le avevano amministrato tutti i trattamenti, fatto prendere droghe di tutti i tipi, ma lei aveva continuato a morire fino alla morte.
“E colpa mia”. Credevo di averlo soltanto pensato, ma avevo parlato a voce alta.
“Ma che dice? Che c’entra lei?” disse il vecchio, sorridendo ancora.
Le ho preso la vita. La voce, la mia, urlava contro le tempie.
“E adesso, lei è rimasto solo?”
“Marcella era figlia unica. Mia moglie non gliel’ha fatta a sopportare. Se ne è andata pure lei, qualche anno dopo. Io sono restato.”
Non potevo più guardarlo o ascoltarlo parlare, scappai precipitosamente, mi gettai per le scale, corsi in strada urlando come una demente. La gente mi guardava tra l’indignato e il divertito. In tutto questo tempo, la città era diventata pudibonda, tutta presa dagli affari, ciascuno pensava solo al suo business, o fingeva di pensarci, per fare come gli altri. Non c’era più posto per Marcella e per me.
E’per questo che sono venuta qui, dottore.
Paola De Luca
Aprile 2007
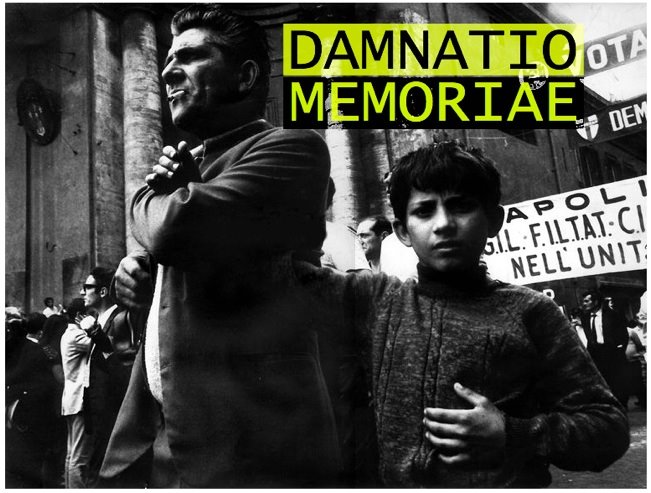

Nessun commento:
Posta un commento
Questa è la Pattumiera. Ma non pubblica qualsiasi monnezza venga lasciata qui. I commenti sono di chi li scrive, che non si offenderà se non ha risposta.